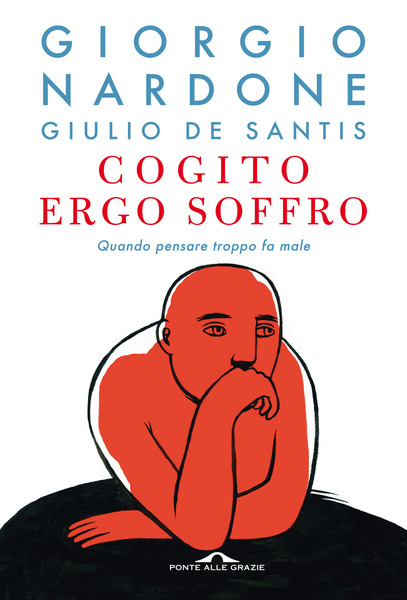Cenni sulla teoria dei sistemi – di Giulio De Santis -Psicologo Milano-Bologna-San Benedetto del Tronto
Definizione di sistema
In questa sede mi limiterò a prendere in considerazione solo certi aspetti dei sistemi interattivi in corso, in particolar modo la famiglia in quanto sistema. Parafrasando il libro di Watzlawick, Beavin e Jackson “Pragmatica della comunicazione umana”, una delle opere che hanno gettato le basi del modello dell’M.R.I., è giusto passare in rassegna ad una introduzione sulla altrimenti vastissima mole di lavoro volto alla formazione della teoria dei sistemi.
Un sistema, secondo la definizione di Hall e Fagen, è «un insieme di oggetti e di relazioni tra gli oggetti e tra i loro attributi» (Hall, Fagen, 1956, pp 18-28), dove gli oggetti sono componenti o parti del sistema, gli attributi sono le proprietà degli oggetti e le relazioni tengono insieme il sistema. Gli autori fanno poi notare come ogni oggetto sia specificato dai suoi attributi. Riferendoci agli individui come agli “oggetti” (sistema oggetti), i loro comportamenti di comunicazione sono gli attributi che servono ad identificarli (invece che gli attributi intrapsichici).
La generalità e la indeterminatezza della definizione sopra citata si possono ridurre se si precisa il significato del termine “relazione”. Hall e Fragen precisano:
che le relazioni che dobbiamo considerare nel contesto di un dato insieme di oggetti dipendono dal problema in questione poiché vengono incluse le relazioni importanti o interessanti ed escluse quelle banali o irrilevanti. Decidere quali relazioni siano importanti e quali banali spetta alla persona che si occupa del problema, cioè la questione della banalità è relativa all’interesse che si ha per il problema.
Qui l’aspetto che è importante, come fanno notare gli autori, non è il contenuto della comunicazione in sé, ma l’aspetto di relazione (“comando”) della comunicazione umana, si può dunque dire che sono sistemi interattivi Due o più comunicanti impegnati nel processo di definire la natura della loro relazione (o che si trovano ad un livello tale per farlo).
I sistemi viventi sono sistemi aperti. I sistemi aperti scambiano materiali, energie o informazione con il loro ambiente. Un sistema è chiuso se non c’è alcuna immissione o emissione di energia in nessuna delle sue forme, quali informazione, calore, sostanze fisiche ecc., e quindi nessun cambiamento dei suoi componenti (Hall, Fagen, 1956, pp 18-28).
Quando si definisce un sistema è importante definire anche il suo ambiente; sempre secondo Hall e Fagen: «L’ambiente di un dato sistema è costituito dall’insieme di tutti gli oggetti che sono tali che un cambiamento nei loro attributi influenza il sistema e anche di quegli oggetti i cui attributi sono cambiati dal comportamento del sistema» (Hall, Fagen, 1956, pp 18-28). Gli autori stessi ammettono che: «l’ipotesi fa sorgere spontanea una domanda: quando si può dire che un oggetto appartiene al sistema e quando appartiene all’ambiente? Se un oggetto reagisce con l sistema nel modo che abbiamo appena descritto, perché non dovremmo considerarlo una parte del sistema? Non si può dare una risposta precisa. In un certo senso, un sistema costituisce col suo ambiente l’universo di tutte le cose interessanti di un dato contesto. La suddivisione di tale universo in due insiemi, sistema e ambiente, si può fare in molti modi ma sono in realtà del tutto arbitrari…
Risulta chiaro dalla definizione di sistema e di ambiente che ogni sistema dato si può ulteriormente suddividere in sottosistemi e gli oggetti che appartengono ad un sottosistema si possono benissimo considerare che facciano parte dell’ambiente di un altro sottosistema» (Hall, Fagen, 1956, pp 18-28).
Concentrando l’attenzione sui sistemi aperti gli autori vanno a definire quelle che sono le proprietà formali macroscopiche dei sistemi aperti in quanto esse si applicano all’interazione, ed è sull’interazione che si è basato il lavoro del gruppo di Palo Alto per sviluppare quella che sarà l’evoluzione della teoria di Don D. Jackson.
La famiglia in quanto sistema
Tutto quello fin qui detto spinge a considerare in modo più formale la famiglia in quanto sistema. Jackson ha proposto un modello simile per l’interazione della famiglia quando ha elaborato il concetto di “omeostasi familiare” (Jackson, 1957, pp. 79-90).
Osservò che le famiglie di pazienti psichiatrici manifestavano ripercussioni violente (depressione, attacchi somatici e simili) quando il paziente migliorava, per cui postulò che tali comportamenti e forse anche la malattia del paziente, erano “meccanismi omeostatici” che operavano per restituire al sistema osservato il suo precario equilibrio. Intendendo la famiglia come sistema si possono applicare ad essa gli stessi principi di Totalità, Non Sommatività e Retroazione/Omeostasi che si applicano ai sistemi organici viventi aperti.
Il principio di Totalità applicato al sistema famiglia suggerisce che il comportamento di ogni individuo all’interno della famiglia è in rapporto con il comportamento di tutti gli altri membri (o in dipendenza da esso) (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, pp. 108-128).
Quando un membro della famiglia ha un miglioramento o un peggioramento, questi cambiamenti hanno un effetto sugli altri membri della famiglia, un effetto che inciderà a seconda della loro salute psicologica, sociale o fisica.
Il principio di Non Sommatività suggerisce che l’analisi di una famiglia non è la somma delle analisi dei suoi componenti. Molte qualità individuali dei membri sono in realtà proprie del sistema (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, pp. 108-128). Dalle ricerche di Fry (Fry, 1962, pp. 245-252), risulta evidente come tra i coniugi ci sia un’interdipendenza che pervade in forme assai sottili il comportamento di ogni coppia. L’autore rileva come i sintomi del paziente sembrano proteggere il coniuge e a sostegno di questa tesi fa notare che l’inizio dei sintomi è tipicamente in correlazione con un cambiamento nella situazione di vita del coniuge.
In ultima analisi, secondo il principio della Retroazione/Omeostasi il sistema familiare reagisce ai dati (azione dei membri della famiglia e circostanze ambientali) e li modifica. Si deve considerare la natura del sistema e dei suoi meccanismi di retroazione come pure la natura dei dati in ingresso (equifinalità). Alcune famiglie riescono ad incassare i colpi di grandi disgrazie e magari a trasformarli in elementi che le rendono anche più unite; altre sembrano incapaci di superare le crisi più insignificanti. Ancor più grave è il caso di quelle famiglie di pazienti schizofrenici che sembrano incapaci di accettare le inevitabili manifestazioni di maturità del loro figlio e che reagiscono a tali “deviazioni” etichettandole malate o cattive (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, pp. 108-128).
Dr. Giulio De Santis
PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA
Specialista in
PSICOTERAPIA BREVE STRATEGICA
Affiliato al CTS di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone
Coordinatore CTS – Bologna
Riceve a: Milano, Bologna, San Benedetto del Tronto
Tel.: 3333763710 e-mail: desantisgiulio@gmail.com